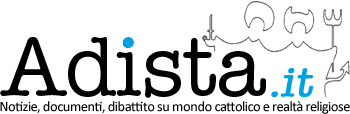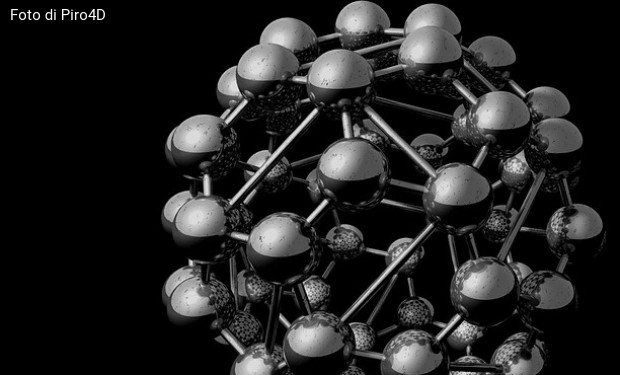
Corresponsabilità di uomini e donne nella Chiesa
Tratto da: Adista Documenti n° 42 del 09/12/2017
Per l'introduzione a questo articolo, clicca qui
Se una cosa mi rallegra dopo quarant’anni di insegnamento è constatare quanto le donne si siano moltiplicate su un percorso che quando io cominciai ne contava veramente poche. Più le generazioni vanno avanti e più mi rallegro e più si accresce la mia fiducia per il futuro. Detto ciò, ho preparato uno schema e brevemente riassunto quello che vorrei dire. Lo schema è alquanto articolato, e se volessi svolgerlo per intero ci vorrebbe assai più tempo di quello che mi è dato. Proporrò piuttosto dei flash problematici per suscitare la discussione. Ho ascoltato con molto interesse e a tratti anche con molta insofferenza quanto è stato detto sinora. Per me il problema è quello di una articolazione strutturale della Chiesa che non è più sostenibile; di una pratica e di una teoria ecclesiale ed ecclesiologica che, secondo me, è arrivata al capolinea. E allora quanto evoca stereotipie stantie (anche con le migliori intenzioni e soprattutto con sentimenti di sincera apertura di cuore) suscita in me reazioni violente. Più trovo interlocutori sinceri nel riproporre il vecchio, più mi scopro intollerante. Devo aggiungere che avendo compiuto settant’anni e non essendo più obbligata alle strettoie di una missio canonica mi sento assolutamente libera di dire quello che penso. Invito se mai voi a operare il giusto discernimento. Devo dire ancora – ed ho avuto la fortuna di viverlo negli ultimi anni di insegnamento – che il tornado papa Francesco ci ha molto liberati. Personalmente io sono passata veramente da una fase di angoscia a una di autentica liberazione. Ricordo che all’inizio quasi del pontificato commentando le letture del giorno ebbe a dire (a noi teologi, è chiaro) che se pure ci arrivavano le lettere autorevoli di censura, le tenessimo nel cassetto e continuassimo a lavorare. Mi sono detta allora: “Finalmente sono finiti i tempi dei processi in contumacia!”.
La testimonianza di Rm 16
Comincio con l’evocare quello che, nello schema, ho indicato come un “frammento testimoniale di sinergia di genere”, non perché mi cimenterò in una lettura o in un’interpretazione del capitolo 16 della Lettera ai Romani, ma per richiamare come ci sia stato un tempo nella Chiesa in cui uomini e donne hanno lavorato insieme, con mansioni analoghe. Un tempo in cui un certo lessico relativo ai compiti era grosso modo uguale per gli uomini e per le donne. Sappiamo che in Romani 16 ricorre il termine diaconessa (che si è perduto nella traduzione ultima della CEI); ricorre il termine apostolo riferito a una donna (e in passato se ne è interpretato il nome come se fosse un maschio); ricorre il termine synergos e altri ancora che, se usati al maschile, tranquillamente ci avrebbero consentito di affermare che in questione fossero ministri “ordinati”. Questa poi è una evidente mistificazione perché, che io sappia, nel Nuovo Testamento non ci sono né ordinazioni né riti che riconducibili ad abilitazioni di tipo sacramentale. Il lessico ministeriale in senso stretto comincia a venir fuori nel II-III secolo e la sua stessa comprensione va mutando sino a cristallizzarsi poi nel Medioevo. Però continuiamo acriticamente a farne uso e non pensiamo neppure che “sacerdote”, ad esempio, è una parola blasfema nel contesto della comunità cristiana. Per non parlare del termine “sacrificio” che poco ha a che fare con la prassi cristiana. Mi vengono in mente certe omelie dell’800 in cui Maria ai piedi della croce chiedeva a Dio padre: “Afferra il pugnale, trafiggilo, affretta la salvezza dell’umanità”. Immaginatevi se Maria ai piedi della croce poteva mai nutrire sentimenti di questo genere o se il sacrificio, sia nel senso di sacrum facere sia nel senso di una oblatività sanguinolenta grazie alla quale la divinità viene placata, è compatibile con la buona novella del Regno di Dio. Senza dimenticare ancora che siamo noi i testimoni e i banditori della buona novella, ma abbiamo messo da parte sia la novella sia la gioia che le è propria.
Fraintendimenti e modelli di Chiesa
Per me, dunque, Romani 16, che è stato a lungo studiato, sul quale le mie colleghe bibliste hanno offerto una puntuale lettura di tutte le sfumature, è veramente uno spartito di Chiesa (anzi di “Chiese”) in cui uomini e donne hanno le stesse responsabilità; hanno anche pure le loro “beghe”, intendiamoci, perché non è che sia pacifiche alcune situazioni lì ricordate, ma quantomeno non ci sono né gerarchia né sacralità; non c’è niente di tutto quello che noi pian piano abbiamo aggiunto. Quella, dunque, che oggi chiamiamo corresponsabilità di uomini e donne nella Chiesa, probabilmente era l’esperito, per quanto umanamente possibile, delle prime comunità cristiane (e anche lì non bisogna idealizzare e proiettare i nostri desiderata e le nostre acquisizioni). C’è stato in partenza un modello egalitario, assai evidente soprattutto nel contesto martiriale. Sappiamo bene come di fronte al martirio non c’è stata differenza tra uomini e donne. Ci insegna la storia che la differenza subentra non appena un gruppo acquisisce il potere. Fino a quando bisogna lottare, testimoniare e morire non c’è differenza tra uomini e donne. Anzi non ci sono discriminazioni né sociali né culturali, come mostra il caso di Blandina, una giovanissima schiava. Appena si stabilizza la situazione, la prima cosa che viene fatta fuori sono le donne.
Al modello martiriale, egalitario, anzi l’unico profondamente e autenticamente egalitario, è subentrato nella vicenda cristiana il modello imperiale, un modello gerarchico, un modello fondato sulla mistica dell’uno. L’uno per definizione non ammette la pluralità; anzi, ogni pluralità è offesa, è scissione, è decadimento. E badate bene, la fede cristiana è stata veramente geniale nel declinare insieme unicità e trinità di Dio. Il nostro Dio unitrino scioglie una delle aporie più tragiche: la contrapposizione uno-molti comprendendo Dio nel segno appunto dell’unità e della pluralità, di più della differenza che non ne annulla l’unicità ma la declina come ineffabile alterità. Come è stato ricordato stamattina, abbiamo un Dio plurale, un Dio differente, un Dio in reciprocità, nel vis-à-vis permanente e straordinario delle divine Persone.
Il modello imperiale, la mistica e la gerarchia dell’uno che lo caratterizza, conosce figure diverse nella storia, ma in esso non cambia il rapporto uomini/donne. In partenza, voglio dire nell’età dei padri – e lo ha messo in risalto Kari Børresen – emerge il binomio “subordinazione/equivalenza”. Il cristianesimo, cioè, afferma l’equivalenza uomo- donna nell’ordine nella grazia - brave donne, fatevi sante, più sante degli uomini; ma lasciate perdere la storia, lasciate perdere la Chiesa perché non sono cose vostre. Questo modello le donne provano a metterlo in questione e spesso e volentieri ci riescono, ma non creano tradizione duratura. La cosiddetta tradizione alternativa, che pure c’è ed è significativa, è minoritaria; succede sempre qualcosa che riporta le donne nella condizione di subordinazione considerata loro propria. Il che mi induce ad allertare chi mi ascolta perché non è detto che la tendenza del presente sia risolutiva. Occorre proprio vigilare perché a ritornare indietro si fa presto (sempre che abbiamo del tutto raggiunto ciò per cui abbiamo lottato).
Il modello imperiale, ripeto, è incrinato dalle donne: lo incrinano le sante donne, le monache; lo incrina il diritto che il monachesimo dà alle donne di accedere alla cultura (cioè a pregare con la Bibbia e quindi a saperla leggere e commentare); lo incrina la teologia medievale delle grandi mistiche, delle grandi profetesse; lo incrina la loro nominazione al femminile di Dio, ecc. Ma permane sempre l’ipoteca gerarchica, che ripropone nell’umano il modello presunto di un divino onnipotente, eterno, immutabile, impassibile e di fronte al quale, visto che è il maschio a riproporlo nella sua interezza, la donna è seconda e dunque ontologicamente diversa: al punto tale che malgrado l’affermazione biblica della imago Dei ci si porrà il problema se le donne abbiano un’anima o meno. E nello stesso leggere l’imago Dei si dirà che la donna è immagine in quanto homo, non in quanto mulier, perché come femmina non può assolutamente essere ad immagine di Dio. Lo è (grazie per la gentilezza) in quanto fa parte dell’umanità. Però poi, nella vita concreta di ogni giorno, questo discorso giunge fino alle proposte ecclesiologiche recenti che continuano a ontologizzare la subordinazione della donna che è e resta seconda nell’ordine del “principio”. Inutile dire che non mi conforta che di questa secondarietà si faccia una nuvola melensa dove le donne e innanzitutto Maria brillino nel primato della grazia e della santità. Di fatto le donne non contano nella loro concretezza e restano subordinate.
Il modello societario comporta novità nella strutturazione della Chiesa. E, al riguardo, va rilevato come ci sia stato sempre detto che nulla muta, che noi crediamo sempre e soltanto le stesse cose. Il che è falso perché abbiamo costruito modelli di Chiesa assolutamente conformi ai modelli sociali e culturali che man mano sono elaborati. Oggi seguitiamo difenderli come se fossero modelli rivelati, come se la Chiesa dovesse essere monarchica per divina istituzione. La monarchia è una nostra invenzione: siamo diventati monarchici quando c’erano le monarchie; siamo diventati imperiali quando c’era l’impero; ci siamo definiti societas quando è prevalso il concetto di società e di patto sociale, e poi collezionando tutte queste cose siamo al punto in cui siamo…
Per me il momento di svolta è il Vaticano II, che non spunta come un fungo ma è preceduto da una grandissima fatica, spesso repressa, condannata, ridicolizzata. Diciamo che dalla fine dell’800 sino agli anni ’50 è stata ingaggiata una lotta per provare a ridire la fede in termini che stabilissero un dialogo col mondo moderno. Poi è arrivato quel grandissimo profeta che è stato papa Giovanni, che non era né scemo, né devoto nel senso infantile del termine, ma era una persona colta, che aveva vissuto sulla sua pelle la temperie modernista e quindi sapeva cos’era successo. Da papa Giovanni si mette in moto la novità del Vaticano II e della sua svolta. Il mutamento, lo sapete, è nel pensare la Chiesa come evento koinonico e sinodale. Direi più in senso koinonico che sinodale perché la sinodalità è qualcosa che abbiamo acquisito dopo, per peso proprio del pensare la Chiesa come comunione. Se la Chiesa è popolo di Dio, se è comunione in quanto popolo di Dio, il popolo di Dio è un popolo pellegrinante e in cammino. La sinodalità, dunque, prima ancora di essere un esercizio di corresponsabilità, è un camminare insieme verso Cristo che torna. Ovviamente in questa riscoperta del modello koinonico e nelle sfaccettature del modello sinodale che cosa emerge? Emerge l’utopia originaria della fraternità/sororità, emerge il disegno trinitario (se lo avessimo messo in pratica avremmo davvero cambiato la società senza dar luogo a tutti gli scempi e le scelleratezze che l’hanno caratterizzata e che la caratterizzano), ed emerge un modello inclusivo, che è nel segno della differenza, perché al cuore del mistero trinitario – lo abbiamo detto – c’è l’alterità.
La riscoperta della soggettualità battesimale
Il popolo di Dio è dunque un popolo che parte dalla trinità e va verso la trinità; è un popolo di fratelli e sorelle, di uomini e donne, segnato da quegli elementi costitutivi che lo rendono, appunto, popolo di Dio. E il punto di partenza, la chiave di volta è l’iniziazione cristiana. Noi diventiamo cristiani attraverso il battesimo, la confermazione, l’eucarestia. Stamattina si poneva il problema dell’abilitazione: scusatemi, ma cos’è la crismazione se non l’abilitazione a ricevere il corpo e il sangue del Signore? Il rito dice che il credente che ha concluso la sua iniziazione si comunica perché è diventato cristiano pleno iure, ossia è passato dal lavacro battesimale, ha ricevuto l’unzione dello Spirito e dunque accede in pienezza a quello che è il vertice della koinonia, la partecipazione al corpo eucaristico del Signore. La Chiesa corpo si nutre del corpo del suo Signore. E anche qui potremmo aprire infinite parentesi perché la metafora del corpo è sicuramente tale, però c’è tutto un gioco che tra l’altro smentisce la nostra attitudine nei confronti del corpo, la sua demonizzazione, e una serie di cose connesse che hanno caratterizzato nel tempo la cristianità.
Cosa posso dire sulla corresponsabilità? Tutto è stato già detto. Si potrebbe dire che sia rispondere insieme all’interpellanza. Corresponsabilità è acquisire il diritto/dovere di fare tutti, nella Chiesa, tutto. Cioè in ordine a quello che costituisce la Chiesa – cioè la Parola, la lode, la cura reciproca – non ci sono persone che non hanno autorevolezza; tutti/e ce l’hanno alla stessa maniera, perché il discorso fondativo della loro autorevolezza è appunto l’iniziazione cristiana. Tutti siamo battezzati e battezzate, tutti siamo cresimati e cresimate, tutti siamo partecipi dell’eucarestia, uomini e donne, e da lì vengono fuori i diritti e i doveri. Naturalmente detto così il discorso può apparire semplicistico e riduttivo. Eppure a monte dell’iniziazione stanno i costitutivi ecclesiogenetici: cioè ciò a partire da cui diciamo la Chiesa, il compito della Chiesa, il compito nostro di cristiani e così via. L’archè, il cominciamento, è l’iniziazione cristiana e questo ce lo attesta la Scrittura: si diventa cristiani attraverso l’acqua battesimale e si partecipa alla cena del Signore secondo quelle che sono le diverse tradizioni. Ora essere portatori del diritto/dovere dell’annuncio è qualcosa da cui siamo stati, parlo dei laici e delle donne, lungamente privati anche se poi la storia della catechesi mostra una nostra permanente soggettualità. Pensate alla scuola catechetica di Alessandria fondata da un laico e nella quale hanno insegnato laici; pensate al ruolo catechetico delle donne, anche monache, nel contesto dello slancio missionario relativamente al quale i monasteri costituivano gli avamposti, magari subendo il martirio. Le donne c’erano e, ovviamente, c’erano anche gli uomini e non parlo solo dei chierici o dei religiosi.
E nell’ambito dell’annuncio, della parola, come dimenticare la profezia? Al riguardo non c’è mai stata discriminazione tra uomini e donne, parlo della profezia comune e dunque del discernimento e della testimonianza. Ma parlo anche della profezia carismatica, nel senso che non si può mettere il bavaglio allo Spirito: là dove egli soffia, che siano uomini o donne, per grazia di Dio profetizzano. Analogo è il discorso della lode: la soggettualità della comunità concelebrante (come l’ha giustamente chiamata Serena Noceti anche se la Congregazione del Culto in altri tempi ha trovato di che ridire). Che senso ha che un prete si dica la sua Messa? Che cos’è, devozione? È un servizio, ma non è un servizio “reso a”, è un’azione di convergenza degli uni e degli altri: Lumen gentium 10 mi pare abbastanza chiara al riguardo.
Vale lo stesso per la cura reciproca degli uni nei confronti degli altri. Pensare che la cura pastorale sia affidata soltanto ai chierici è veramente una cosa senza senso. Basterebbe pensare alla fatica che il magistero ha dovuto fare per riconoscere quello che poi fu chiamato “l’apostolato dei laici”, perché sembrava che l’espressione fosse un ossimoro, un’incongruenza: come potevano i laici fare apostolato? Se ad un certo punto siamo arrivati a questa formula è perché si è capito che non era possibile fare diversamente. Ora ripeto, tutte queste cose per me si concretizzano nel vissuto delle Chiese e appellano ai carismi che lo Spirito elargisce a ciascuno e che, comunque afferenti alla sfera o della Parola o della lode o della reciproca cura, caratterizzano ciascuno di noi in modo particolare. Per cui la comunità è chiamata ad un discernimento continuo, visto che lo sport ecclesiale più diffuso è quello dello spegnere i carismi: tu hai il carisma della buona cucina, vai a fare la portinaia; tu hai il carisma della portinaia, vai a fare l’intellettuale… sto scherzando ma ricordo certe confidenze ricevute da religiose che si trovavano ad avere compiti per i quali erano completamente negate. Lo porto come esempio di ciò che avviene nelle nostre comunità. Sei fatto per fare il vescovo? Per miracolo sarai sacrestano. Sei fatto per fare il sacrestano? Ti facciamo vescovo. Sei un traffichino e dunque dovresti essere messo fuori? No, hai meriti, sei un manager, abbiamo bisogno di te per fare i soldi. Lo sport ecclesiale di vescovi e responsabili di comunità (anche religiosi) in questo momento è quello di far soldi. Visto che diminuiscono le risorse “umane”, bisogna vendere, investire, poi magari con la finanza creativa si perde tutto e si deve far fronte a perdite ingenti.
La Chiesa che verrà
Con altri – i miei colleghi della Società Italiana per la Ricerca teologica – da tempo sto fantasticando sulla Chiesa che verrà. Intendiamoci, la Chiesa che verrà, come è stato detto correttamente stamattina, verrà perché lo Spirito la vuole, non siamo noi che la possiamo determinare. Però come teologi e come popolo di Dio abbiamo il dovere di discernere isegni dei tempi e dunque di stare in guardia per capire qual è la direzione verso cui la spinge lo Spirito. Non so se l’Occidente vedrà la fine del cristianesimo; sicuramente le Chiese muoiono, pensate all’Africa dove c’erano Chiese fiorenti che non ci sono più; pensate al Medio Oriente dove c’erano Chiese fiorenti che non ci sono più. Potrebbe capitare tutto questo anche alla Chiesa di Roma o alle Chiese d’Europa; la Chiesa ci sarà altrove, questo non è un problema. Però il nodo secondo me è quello dell’ecclesiogenesi: cioè dobbiamo reinventare la Chiesa assumendo come modello quella pluralità di accadimento che ha caratterizzato la comunità apostolica; nella quale non c’era la Chiesa ma “le Chiese”, non c’era il ministero ma c’erano “i ministeri”. Se torniamo alla Scrittura, se riandiamo alla tradizione antiochena, alla tradizione delle Chiese paoline, alla tradizione giovannea, troviamo modelli diversificati di Chiese. E anche all’interno dell’epistolario paolino, come è stato stamattina ricordato, una cosa è Paolo “storico”, una cosa sono le Chiese paoline di seconda generazione, e una cosa sono le Chiese paoline di terza generazione, solo che noi abbiamo fatto delle scelte per motivazioni di tipo ideologico e politico che hanno visto il prevalere di un modello unico anziché una pluralità di modelli.
Come immagino la Chiesa che verrà? Come vorrei che fosse la Chiesa che verrà, una Chiesa di uomini e di donne? Vi ho proposto nello schema un settenario. Provo a riproporlo.
- Una Chiesa “declericalizzata”, cioè nella quale dichiarassimo impropri i termini laico, chierico, religioso/a, perché o compiamo la rivoluzione semantica che restituisce a questi termini la valenza onnicomprensiva che avevano alle origini, o altrimenti meglio lasciar perdere. Cleros era detto del popolo di Dio tutto, non di una sua porzione. Laos vuol dire popolo. É vero che è stato dimostrato che i suffissi in ikos dicono una “parte contrapposta”, ma ciò che occorre fare è operare una rivoluzione semantica che riconduce i laici al laos, i chierici al cleros sinonimo anch’esso del popolo. Una Chiesa declericalizzata è anche anche desacralizzata, perché il delirio di onnipotenza che caratterizza il sentirsi uomini del sacro, purtroppo, fa calpestare tutte le regole, morali, economiche, di buona educazione, non c’è decalogo o codice che tenga. Naturalmente ciò non vale per tutti, ma la presunzione ontologica d’essere diversi e altri, questa purtroppo è frutto di una formazione ben lontana dall’essere qualificata come umanamente deviante.
- Una Chiesa “degerarchizzata”. La gerarchizzazione non appartiene al cristianesimo. Non so – dialogo a distanza con il relatore del mattino – se la lavanda dei piedi ha un valore eucaristico o un valore emblematico, ma sicuramente colui che si mette il grembiule e lava i piedi si pone e propone un atteggiamento di servizio. D’accordo il diacono non sarà il dulos, lo schiavo, però in altri punti della Scrittura a Cristo viene attribuita proprio questo termine. Il modello è quello di stare tra gli altri come colui che serve; che il primo sia l’ultimo… Ciò è il rovesciamento di ogni presunta gerarchizzazione. Una Chiesa declericalizzata e degerarchizzata diventa autenticamente e pienamente inclusiva, perché non ha più fondamento ontologico la gerarchia di genere e finisce l’aura di sacralità che caratterizza il maschio; per contro cade la pretesa impurità che umilia ed esclude la donna. Perché siamo escluse? Perché considerate impure. Diventa tabù escludente la potenza femminile, e cioè il rapporto con il sangue, il rapporto con la vita. E questa oggi è farneticazione pura. Sono cose comprensibili in un contesto mitico o prescientifico, non oggi che abbiamo in mano altri strumenti. Dunque una Chiesa inclusiva perché declericalizzata e degerarchizzata, dove uomini e donne rivendichino la titolarità acquisita, rivendichino la competenza acquisita. Ma uomini e donne insieme, perché il problema della “conversione”, è stato detto anche questo, non riguarda solo le donne, ma uomini e donne insieme.
- Una Chiesa “decentrata”. Basta con la Chiesa romana che addirittura cambia il nome alle basiliche patriarcali e le fa diventare papali perché il papa è più del patriarca. Sono deliri. Non possiamo imporre a tutto il mondo, tranne a quelle piccole nicchie che appartengono alle Chiese orientali, l’uniformità del rito. È chiaro che clima e luogo interferiscono e che bisogna assecondarli; non posso rendere lode a Dio in Scandinavia così come rendo lode in centro Africa – basta solo la presenza del sole per imprimere un bioritmo diverso che esige un’espressività diversa. Dunque decentramento amministrativo, istituzione di una pluralità di patriarcati, revisione della struttura elettiva del vescovo di Roma, visto che un simulacro, un segno culturalmente e sociologicamente dobbiamo pure averlo che rappresenti l’unità. Ma segno, simbolo, non despota (che poi non comanda lui ma il vicario del vicario del vicario, come ricordava il Belli in un suo sonetto).
- Una Chiesa “pluri-culturata”. Il futuro è altrove. Ci sono culture che del nostro vocabolario religioso recepiscono solo una parte, perché concetti che per noi sono ovvi, sono loro estranei. Eppure la buona novella la dobbiamo portare. Bisogna, dunque, ad ogni costo che ci mettiamo in un atteggiamento di reciproco dialogo e ascolto cultura religiosa accanto a cultura religiosa altra, non per imporre il nostro punto di vista, ma per trovare nella reciproca ricchezza modalità nuove del dire la fede.
- Una Chiesa “solidale”. Capisco la crisi intimistica, capisco la mistica, capisco la spiritualità, ma non mi dite che ripristinando l’adorazione eucaristica abbiamo risolto i problemi! Adesso a Roma in qualsiasi chiesa andiate trovate scritto “adorazione dall’ora tal dei tali all’ora tal dei tali” oppure adorazione “tutto il giorno”. Questa, non vi scandalizzate, è idolatria. Non parlo ovviamente dell’adorare, del pregare riconoscendo presente il corpo e il sangue del Signore. Mi riferisco all’ostentazione d’ori e argenti, agli effluvi d’incenso, a tutte quelle forme trionfalistiche che con l’adorazione come riconoscimento del proprio creaturale hanno ben poco in comune. Nemmeno il Concilio di Trento – che pure ha scritto delle pagine non gloriose circa l’esibire ai protestanti, a loro vergogna, l’eucaristia solennemente portata in processione – ha detto che il fine dell’eucaristia è l’adorazione. L’eucaristia è fatta per essere consumata: è cibo. Un culto eucaristico slegato alla celebrazione è panacea che forse riempie la chiesa per i nostalgici ritorni ai riti dell’infanzia. Ma questo appunto fa regredire non rende coscienti di diritti e doveri. Non rende “corresponsabili”. Quando parlo di una Chiesa solidale mi riferisco ad una Chiesa che non si rifugia nell’intimismo, ma si sporca e va fuori, perché il problema nostro oggi è che siamo stati troppo dentro. Finiamola di guardarci l’ombelico. Usciamo fuori perché è fuori che bisogna portare la buona novella. Non possiamo rinunciare al primato dei poveri, degli esclusi, degli emarginati, delle nuove povertà, dei nuovi problemi, là si gioca la Chiesa, non si gioca dentro. Solidale significa prendere sul serio i problemi dell’oggi, e i problemi di oggi sono la discriminazione uomo donna, la discriminazione di classe, la discriminazione di reddito, la disoccupazione, e tutte le cose altre o consimili a cui bisogna far fronte.
- Questa Chiesa solidale è una Chiesa “in uscita” (lo sto dicendo e lo ripeto, era il sesto punto), perché non può che essere così. Leggiamo nel prologo degli Atti che disse loro di restare a Gerusalemme; ma poi partirono. Negli apocrifi abbiamo tante letture divertenti di questa partenza e poi del ritorno, in particolare per la vergine Maria al momento del suo transito. Il cristianesimo per natura sua deve essere in uscita. Sono sessantottina, e ai miei tempi si diceva: “Chiudiamo le chiese per dieci anni” – poi sembrò una posizione eccessiva. Dico ancora “chiudiamole nei giorni feriali” e andiamo nelle case degli altri, per fare eucarestia perifericamente. Non è dicendo messa, partecipando alla messa in Chiesa nei giorni feriali che realizziamo il nostro compito di lode.
- Infine, quella di cui io parlo è di una Chiesa “in servizio”. Una Chiesa che prende il servizio veramente come un metodo rivoluzionario e controcorrente. Oggi anche a livello civico il concetto di servizio è diventato un non senso. Siamo gli unici che, almeno in teoria, dovremmo rivendicare uno stile diverso, una disponibilità diversa gli uni verso gli altri. Secondo me, se la Chiesa che verrà realizzerà alcune di queste cose, possibilmente tutte, allora la corresponsabilità in essa degli uomini e delle donne non sarà un’utopia ma una realtà.
Vorrei aggiungere una cosa: sono convinta che il vero modo per ricominciare da capo è quella di ricordarsi come è cominciata l’avventura. Bisogna ripartire in piccoli gruppi, in piccole cerchie e in piccole unità, non in polemica con la grande Chiesa, ma affiancando la grande Chiesa. Se non vogliamo essere fagocitati dalla preoccupazione pastorale, dall’organigramma pastorale, da tutti i compiti catechetici, caritativi, liturgici, l’unico modo è ridare fiducia e riconoscere come chiesa piccole unità che, non necessariamente con la presenza di un presbitero, ma partendo dal proprio battesimo e dalla propria iniziazione, si costituiscono con consapevolezza di Chiesa. Allora magari ci sarà qualcuno che farà da coordinatore, lasciandole però nella loro identità e nella loro autentica libertà. Il problema non è di pensare a una pastorale efficiente, il problema è di quello di una conversione radicale a quello che deve essere il movimento di ripartenza della comunità cristiana, e ciò parte dal considerare Chiesa realtà che sino ad oggi non consideriamo tali. Papa Francesco ha parlato della “Chiesa del poliedro”. Ne ha parlatoanche riferendosi alle comunità pentecostali che sono quasi la negazione, per certi aspetti, del concetto di Chiesa. Molto più semplicemente dico che là dove due o tre battezzati, due o tre famiglie si riuniscono per riflettere sulla Parola di Dio, per pregare insieme, per porsi il problema del vicinato, per rispondere ai bisogni civici ed ecclesiali di chi sta loro intorno, lì abbiamo di nuovo una ripartenza di Chiesa e non c’è bisogno di autorizzazioni. anche perché il problema – è il mio chiodo fisso – non siamo noi laici, non sono i religiosi, non sono i chierici… il problema è il ministero: o lo ripensiamo e lo cambiamo radicalmente o altrimenti la Chiesa morirà per asfissia. Perché per il ministero così com’è vissuto e così come ad esso ci si prepara non c’è futuro. Le vie di formazione che abbiamo elaborato, proprio perché sono “seminario” tradiscono la comunità. Se c’è un punto di ripartenza è quello di inventare luoghi formativi nuovi, nei quali per altro uomini e donne siano compresenti.
Come deve fare un prete ad avere un rapporto di normale cordialità con una donna se per cinque, sei anni lo si educa ad averne paura e stigmatizzarla? Sì d’accordo, cameratismo, bacetti, rapporti che oggi sono molto diversi da quelli del passato, ma al dunque, quando questo ragazzo sarà interpellato – perché purtroppo si continua ad ordinarli troppo giovani – non avrà gli strumenti per verificare se la sua vocazione al ministero passava dal celibato o se viceversa passava da un’alterità di tipo sponsale. Ed è una tragedia che i nostri ragazzi vivono. Poi ci scandalizziamo e corriamo ai ripari, ma il problema è questo. All’ordine del giorno, perdonatemi, il problema vero non è il diaconato. Il problema vero è il ministero ecclesiastico come tale.
Foto di Piro4D, tratta da Pixabay, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!